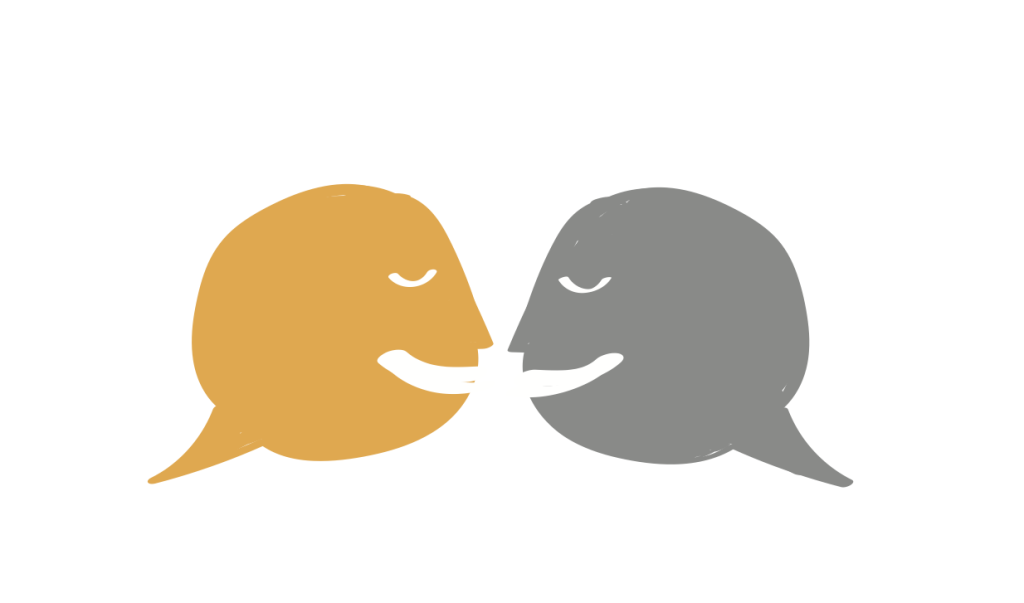
Da due anni stiamo investendo le nostre energie per accreditare la figura professionale del Chief Happiness Officer anche nel nostro Paese. Perché?
Avevamo bisogno di un moltiplicatore di impatto che accelerasse il cambiamento culturale verso modelli più funzionali a gestire la complessità – come quelli offerti dalla Scienza delle Organizzazioni Positive – e che consentisse all’organizzazione di procedere in questo percorso autonomamente, maturando quindi competenze interne.
Le cose accadevano troppo lentamente rispetto al senso di urgenza che ci raccontavano i numeri, l’analisi dei trend, gli studi sugli scenari futuri e la letteratura internazionale.
La lentezza era dovuta non solo alle caratteristiche proprie dei cambiamenti culturali, noi avevamo un ostacolo in più da superare: dovevamo dedicare sempre molto tempo ad “educare” il nostro interlocutore, trasferire contenuto, preparare il terreno e portarlo a bordo. Questo implicava un dispendio di energie reciproche siderali e soprattutto rallentava le potenzialità di innescare cambiamenti reali in tempi saggi.
La lontananza della maggior parte delle aziende da questi linguaggi ha una sua ragione: sono tempi complessi da padroneggiare quindi richiedono un attento studio ma soprattutto accendono la pancia.
Felicità non è un termine neutro, crea resistenza, si aggancia a stereotipi e polarizza le posizioni.
Inoltre la scienza della felicità, così come tutta la letteratura in tema di Org+ e nuovi modelli organizzativi, non entra ancora in modo innovativo (in Italia) nei programmi accademici, nei percorsi post universitari e di alta formazione. Il risultato è che sulle scrivanie di chi guida le aziende, o di chi fa consulenza, arrivano stimoli di superficie che non atterrano nella pratica.
Quali sono le principali obiezioni o le visioni sul ruolo del CHO che generano dubbi, fraintendimenti o in alcuni casi addirittura repulsione, avversione e ostilità?
1. Il CHO è un giullare di corte, una persona che deve dirmi come essere felice, che mi controlla se non sorrido e che vuole vedere sempre tutti al top.
L’immagine che la mente restituisce alla parola “Manager della felicità” (questa volta la traduciamo in italiano perché l’effetto che suscita è decisamente differente), ci fa pensare una persona che a suon di pacche sulle spalle sfreccia su pattini a rotelle tra le scrivanie e le linee di produzione, dispensando sorrisi e lasciando dietro di sé una scia di frustrazione, inconsistenza e fastidio.
In un articolo intitolato “Perché è ora di smettere di ridere del chief happiness officer” si dice: qui da noi nel Regno Unito, siamo scettici. L’idea di un dipendente il cui unico lavoro è rendere felici le persone ci appare ridicola. Pensiamo a infiniti esercizi di team building, costanti esclamazioni di “Ti stai divertendo ?!” e alle guerre con le pistole finte obbligatorie in ufficio”.
Non c’è dubbio che un CHO triste, scontroso, arrogante e maleducato non lo vorrebbe nessuno e che una delle prime sue caratteristiche è legata alla capacità di esercitare una leadership positiva, ma non c’è bisogno di indossare un naso rosso e le parrucche per essere un CHO. Il CHO è un esperto di organizzazioni positive e ha una visione sistemica ed integrata di queste. Per approfondire leggi il Manifesto del CHO e il modello culturale dell’Org+
2. C’è un evidente problema di privacy.
Josh Kovensky su New Repubblic definisce il CHO “il lavoro più inquietante nato in seno alle corporazioni americane”. Il motivo è legato sostanzialmente alla privacy.
Al fine di raggiungere il suo obiettivo molti CHO si rivolgono ai dati per comprendere meglio ciò che rende i dipendenti felici. È qui che entrano in gioco i problemi di privacy. Cosa monitorate per comprendere la felicità dei dipendenti? Messaggi di posta elettronica? Chiamate telefoniche? Utilizzo di internet? Il tempo che un impiegato trascorre alla propria scrivania? Questo rappresenta un’intrusione nelle nostre vite emotive che non dovrebbe essere consentita a nessun tipo di figura, sia essa aziendale o governativa e questo vale indipendentemente dall’intenzione.
Sicuramente siamo difronte ad un aspetto delicato e ad un rischio potenziale. La nostra posizione in merito è legata a ciò che sappiamo essere realmente utile in termini di misurazione e su cui tutti noi che ci occupiamo del tema concordiamo. E’ vero che se non misuri non gestisci ma è anche vero che quello che devi monitorare non è tanto “cosa fanno le persone per essere felici” ma quanto le azioni che intraprendi sono efficaci.
Devi misurare l’efficacia delle tue azioni e per farlo è sufficiente guardare i KPI tradizionali e parlare, osservare, ascoltare.
Esistono app e una vasta tecnologia a supporto, alcune sono invasive altre meno, alcune divertono mentre altre ti aiutano ad apprendere. Se ragioniamo nei contorni dell’Org+, che ha per sua natura un presidio etico, valoriale e umano elevato, questo problema sarà gestito con cura e attenzione estrema pena l’involuzione verso l’incoerenza e la perdita di credibilità e fiducia.
3. Non serve a nulla.
Un articolo comparso su Fast Company nel 2017 titolava “Licenzia il tuo CHO”. L’articolo portava in evidenza diverse questioni in parte collegate ad aspetti che abbiamo già analizzato ma ne aggiunge uno “non vi è alcuna indicazione oggettiva che le persone negli ultimi cento anni abbiano sperimentato un aumento o una diminuzione significativa della loro soddisfazione al lavoro prima dell’era chief happiness officers o dopo il suo avvento. I livelli di engagement globale sono rimasti esattamente gli stessi negli ultimi decenni. In secondo luogo, anche se le aziende potessero in qualche modo aumentare i livelli generali di felicità dei dipendenti, probabilmente non avrebbero prestazioni molto migliori. Non è difficile immaginare ambienti di lavoro felici in cui i dipendenti si divertano troppo per essere produttivi; andare troppo d’accordo può impedire di andare avanti.
Il CHO non ha l’obiettivo di aumentare gli indici di engagement, questo è un outcome che migliorerà automaticamente se l’aziende è stata in grado di generare una cultura organizzativa positiva lavorando su cultura, processi e comportamenti. Inoltre, il punto non è quanto sono cambiati o meno nel corso degli anni gli indici di engagement: questi numeri ci dicono che le persone non si sentono coinvolte e se è tanto o poco non fa la differenza. Quello che importa è che se voglio ridurre la sofferenza, migliorare la vita delle persone e i risultati dell’azienda, dobbiamo guardarli quei numeri e domandarci cosa possiamo fare di diverso.

